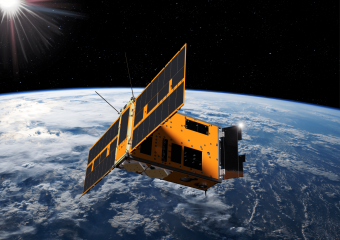A che punto siamo con la transizione energetica, e il passaggio da un sistema ad alta intensità di carbonio a uno sostanzialmente decarbonizzato? La risposta non è facile, e nonostante i progressi ottenuti grazie alla penetrazione delle rinnovabili a livello globale e gli importanti obiettivi fissati dall’accordo di Parigi, i punti di domanda rimangono ancora numerosi.
Tra i diversi fattori che permetteranno un completo ed efficace processo di decarbonizzazione, batterie e sistemi di accumulo (elettrochimico) giocano un ruolo di primo piano: essi infatti possono garantire lo stoccaggio di energia elettrica prodotta in eccesso, permettendo di far fronte all’intermittenza di fonti rinnovabili come eolico e solare. Il settore della generazione, così come quelli industriale, domestico e dei trasporti potrebbero beneficiare in modo significativo una volta che la tecnologia sarà matura e competitiva dal punto di vista economico. Fino a che ciò non accadrà, il ruolo dei combustibili fossili – meglio se a basse emissioni di CO2 – rimarrà centrale per lo sviluppo del pianeta terra e per il benessere dei suoi abitanti.
I molteplici usi di una nuova tecnologia
Il futuro è nello stoccaggio. Se vogliamo realmente raggiungere gli obiettivi fissati dall’accordo di Parigi, ridurre di due gradi centigradi, al massimo, l’aumento della temperatura globale e limitare il più possibile gli effetti devastanti dei cambiamenti climatici su esseri umani e natura, non possiamo fare a meno di compiere un enorme passo avanti nello sviluppo tecnologico di batterie e accumuli.
Non si tratta ovviamente dell’unica tecnologia necessaria per garantire un efficace e sostenibile processo di decarbonizzazione globale, digitalizzazione e big data, carbon capture & storage, biocarburanti, smart metering contribuiranno ad accompagnare la transizione del sistema, ma certamente l’utilizzo degli stoccaggi elettrici a diversi livelli dell’economia e della vita dei cittadini rendono le batterie un fattore di fondamentale importanza. Le batterie, infatti, si apprestano a giocare un ruolo chiave nell’integrazione delle rinnovabili nella rete elettrica, neutralizzandone l’intermittenza che ad oggi ne limita in modo sostanziale l’utilizzo.
Da un lato lo sviluppo di sistemi di accumulo efficienti, economici e ‘smart’ potrà finalmente consentire di immagazzinare l’elettricità in eccesso prodotta durante le ore di massima resa da capacità solare ed eolica, o di stoccare quella generata da centrali termoelettriche, per poi reimmetterla in rete nei i momenti di picco della domanda garantendo un bilanciamento del sistema elettrico. Questo è, ad esempio, il caso del sistema di accumulo Powerpack di Tesla, il primo dei quali è stato collegato ad una centrale eolica localizzata nel sud dell’Australia, in grado di stoccare e rilasciare energia per 30mila abitazioni per un’ora. Sistemi simili sono attualmente operativi anche a Portorico, negli Stati Uniti e in Belgio. Al contempo, unità di accumulo di grandi dimensioni possono essere utilizzate da complessi industriali per stoccare e riutilizzare l’energia elettrica generata in modo indipendente – potenzialmente da fonti rinnovabili, assicurando una gestione ottimale dei carichi. Le mega-batterie permetterebbero infatti lo spostamento dei consumi da una fascia oraria all’altra in modo da ottimizzazione i costi dell’energia e rendere l’attività industriale più efficiente (e sostenibile).
La diffusione su larga scala di batterie e sistemi di accumulo distribuiti potrà avere un impatto significativo anche sulle abitudini di famiglie e individui, spianando la strada a pratiche quali l’autoconsumo domestico da rinnovabili. Va infine considerato il ruolo chiave che le batterie giocano nel settore della mobilità, nel quale i veicoli elettrici rappresentano oggi ancora un ambito di nicchia: grazie al miglioramento delle performance dei sistemi di accumulo – dimensioni, costi, velocità di ricarica e durata sono attualmente non sono ancora ottimali – l’auto elettrica potrà infatti registrare una crescita esponenziale sul mercato soprattutto per l’utilizzo urbano e di medio raggio. Inoltre, nell’ottica di reti elettriche sempre più intelligenti e responsive, le batterie installate sui veicoli elettrici potranno utilizzate durante le fasi di ricarica per gestire flussi di elettricità unidirezionali e bidirezionali e bilanciare in modo distribuito la rete (vehicle-to-grid, V2G).
Un settore strategico che accelererà il processo di transizione
Sul piano globale, la diffusione massiccia di batterie e sistemi di accumulo – associata al progressivo abbattimento dei costi di eolico e solare – potrà garantire una rapida transizione verso un settore energetico (e non solo) fortemente decarbonizzato e, al contempo, favorire il raggiungimento di uno dei principali obiettivi dell’Agenda 2030 della Nazioni Unite: l’accesso all’energia a quel miliardo e mezzo di persone che ancora oggi vive – principalmente in Africa – disconnesso dalla rete e privo di qualsiasi servizio elettrico. Un mercato immenso, nel quale il possesso di tecnologie abilitanti d’avanguardia rappresenta un fattore strategico sia dal punto di vista economico che da quello geopolitico. Secondo le stime dell’IRENA, infatti, la capacità installata dei sistemi di accumulo per uso stazionario crescerà di diciassette volte di qui al 2030 per far fronte alla crescente generazione da rinnovabili. A questa va aggiunta la domanda di batterie per veicoli elettrici, un mercato da circa 700 GWh all’anno nel 2030, per un totale di quasi 250 miliardi di dollari.
Ad oggi, gran parte di questa capacità tecnologica e industriale è localizzata in Asia: l’attuale leader mondiale, la giapponese Panasonic, è incalzata dai giganti cinesi BYD e CATL e dalle coreane LG e Samsung, che insieme controllano quasi il 90 percento del mercato globale. Nel giro di pochi anni, anche trainata da un mercato interno dei veicoli elettrici senza uguali, la produzione cinese è destinata ad aumentare in modo significativo, e raggiungere una quota del 70 percento della produzione mondiale: basti pensare che nel solo 2017 – anno record per le vendite globali di veicoli elettrici con un milione di nuove immatricolazioni – la flotta cinese è cresciuta di quasi 600mila unità (quasi 100mila in più rispetto alle vendite dell’anno precedente), un dato che risulta ancor più straordinario se paragonato ai 200mila veicoli venduti rispettivamente negli Stati Uniti e in Europa. E proprio sull’asse transatlantico si rischia di rimanere irreparabilmente indietro in questo settore strategico. La californiana Tesla, in realtà, sta cercando di recuperare il gap tecnologico e industriale con i competitor asiatici grazie ad una serie di massicci investimenti sia nei mega accumuli che nelle batterie al litio per autoveicoli.
Elon Musk ha infatti recentemente annunciato la partnership con Pacific Gas & Electric Company per la realizzazione di un mega sito di stoccaggio in California da più di 1.1 GWh (quasi dieci volte l’attuale sistema attivo in Australia), mentre nel segmento delle batterie sta lavorando per abbattere sensibilmente l’uso (e i costi derivati da esso) di cobalto, una delle componenti più costose dei sistemi di accumulo per veicoli. Le nuove Tesla Model S, ad esempio, sono passate dall’utilizzo di 11 chilogrammi per unità a meno di 5 chilogrammi nel giro di pochi mesi: qualità e innovazione sono l’unica soluzione per l’azienda di Palo Alto – che sta pianificando la realizzazione di due nuove Gigafactory in Cina ed Europa (probabilmente in Germania) – per rimanere competitiva sul mercato.
L’Europa ancora al palo in tema di batterie
E quella di Tesla (insieme a grandi compagnie asiatiche come CATL e BYD) rischia di rimanere l’unica grande presenza industriale nel vecchio continente in questo settore. Nonostante lo scorso anno la Commissione abbia lanciato un’iniziativa per creare una “Airbus” delle batterie e non perdere il treno di una rivoluzione in grado di trasformare i settori dell’elettricità e dei trasporti, in Europa le cose stentano a decollare. Sebbene le previsioni di mercato siano sostanzialmente rosee, con un terzo delle vendite globali di batterie al litio da oggi al 2025 – circa 200 GWh sui 600 totali – previste in Europa, la capacità del tessuto industriale europeo, ad oggi privo di aziende di portata globale, di far fronte a questa grande opportunità di mercato appare quantomai discutibile.
E a poco rischiano di servire i tentativi di Bruxelles per spingere l’innovazione nel settore: per il biennio 2018-19 l’UE finanzierà 110 milioni di euro per attività di ricerca e sviluppo, davvero troppo poco se paragonati ai 3 miliardi di investimenti al 2020 previsti dalla cinese CATL per quadruplicare la propria produzione di batterie. Nonostante le straordinarie prospettive per il mercato globale delle batterie e dei mega accumuli, alcuni elementi di incertezza limitano ancora la completa espansione del settore.
Il primo, e principale, è legato ai costi e alle prestazioni delle tecnologie disponibili. Sebbene il prezzo delle batterie al litio sia crollato da mille a meno di 300 dollari per KWh ora nel giro di pochi anni, la competitività in termini di costo dei veicoli elettrici nei confronti delle automobili a combustione interna – al netto di incentivi governativi e di altre forme di sostegno – rimane ancora tutta da dimostrare. Oltre ai costi delle batterie, che per rendere i veicoli elettrici competitivi si stima dovranno raggiungere i 100 dollari per KWh, un’altra componente di costo estremamente rilevante è quella dell’infrastruttura da sviluppare per garantire l’accesso a punti di ricarica a un numero crescente di unità presenti nel sistema stradale. Vanno inoltre considerati elementi quali le dimensioni delle batterie stesse, la loro durata ed efficienza, e i tempi di ricarica, che ad oggi contribuiscono a limitare la fruibilità dei veicoli elettrici – soprattutto per tragitti di media e lunga durata – ma che grazie al progresso tecnologico potranno favorire una rapida penetrazione dell’auto elettrica.
Le tante difficoltà per l’approvvigionamento del litio
Un altro elemento, attualmente meno sotto i riflettori, ma da tenere certamente in considerazione è quello dell’accesso alle risorse naturali necessarie per sviluppare e mantenere il futuro mercato delle batterie. Le riserve di litio, in questo contesto di rapida transizione energetica, giocheranno un ruolo centrale: a richiedere attenzione non sono soltanto le implicazioni politiche di una crescente dipendenza per garantire il funzionamento del settore, ma anche quelle di natura prettamente economica. A livello globale, le riserve di litio sono concentrate in un numero limitato di paesi, con il Cile che controlla quasi il 50 percento delle risorse, seguito da Cina, Australia e Argentina rispettivamente con 20 percento, 17 percento e 12 percento. Concentrazione che determina forte volatilità in termini di prezzo, come accaduto nel corso del 2017 quando ad una limitazione della produzione australiana ha fatto fronte una crescita dei prezzi in Cina del 300 percento. In generale, il prezzo del litio è cresciuto in modo esponenziale negli ultimi 15 anni, passando da 1500 dollari per tonnellata nel 2002 agli oltre 9000 nel 2017.
Una tendenza destinata a continuare col crescere della produzione industriale, e a fronte della quale le aziende del settore stanno intraprendendo una necessaria politica di risparmio delle materie prime. Le grandi sfide del settore delle batterie passano da qui, e determineranno le tempistiche con la quale la transizione energetica – inevitabile quanto ancora incerta – potrà finalmente dirsi completa.