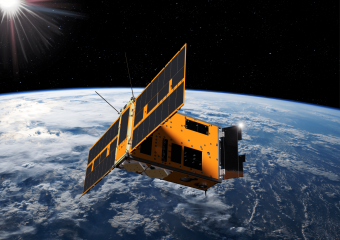Il rapido mutamento del panorama energetico ha vaste implicazioni per le industrie energetiche di tutto il mondo e per i suoi protagonisti, tra cui le compagnie petrolifere e i paesi esportatori di petrolio. Nonostante la transizione energetica sia ricca di incognite, l’aumento della quota delle rinnovabili nel mix energetico sembra, stando alle più accreditate previsioni, un dato di fatto acquisito.
![]()
In effetti, la recente deflazione dei costi dell’energia rinnovabile ha rappresentato una vera e propria rivoluzione per il settore energetico globale. Cinque anni fa i costi dell’eolico statunitense erano di 11 centesimi di dollaro/kWh e quelli del solare di 17 centesimi di dollaro/kWh, considerando tutti i costi diretti e indiretti, compresi quelli del capitale per le infrastrutture.
Senza il supporto dei sussidi, nessuna delle due energie sarebbe stata commercializzabile. Stando alle stime dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), il costo medio globale di eolico e solare onshore è ora sceso rispettivamente a 5 centesimi/kWh e 6 centesimi/kWh. Per quanto riguarda il solare, il record toccato negli EAU, nel 2016, con l’offerta da 2,4 centesimi/kWh è stato battuto a ottobre 2017 un’ulteriore offerta da 1,8 centesimi/kWh da parte di Masdar ed EDF per l’impianto da 300 MW di Sakaka, in Arabia Saudita. Anche l’energia eolica ha fatto registrare una sensibile flessione dei costi, in attesa che un’ulteriore ribasso possa arrivare a toccare i 4 centesimi/kWh entro il 2020. Di conseguenza, a livello di impianto ed escludendo i costi legati all’intermittenza, l’eolico e il solare si stanno affermando, globalmente, come fonti di energia fortemente competitive.
Con la transizione energetica che dovrebbe produrre cambiamenti strutturali sui mercati energetici di tutto il mondo, compagnie petrolifere e paesi esportatori di petrolio si troveranno ad affrontare sfide impegnative. Le prime assisteranno a una disruption dei propri modelli di business e dovranno trovare il modo per integrare le risorse a basso tenore di carbonio nel proprio portfolio. Dal canto loro, i paesi esportatori di petrolio con un rapporto R/P (Riserve/Produzione) consolidato da anni, dovranno riuscire a monetizzare la propria ampia base di riserve, andando probabilmente incontro ad un calo dei proventi delle esportazioni, il che, data la forte dipendenza dagli introiti del petrolio, potrebbe alterarne il benessere socio-economico. Dunque la domanda fondamentale è la seguente: che posizione dovrebbero assumere le compagnie petrolifere e i paesi esportatori di petrolio nell’era della transizione per assicurarsi di partecipare alla “rivoluzione” delle rinnovabili e garantirsi stabilità a lungo termine?
Una transizione energetica dal ritmo incerto
La transizione energetica consiste in una trasformazione radicale del sistema energetico, che passa da un modello esistente a un nuovo paradigma. Si tratta dunque di un fenomeno complesso, ben oltre la semplice sostituzione di una fonte di energia con un’altra. In sostanza, la transizione energetica comporta cambiamenti rispetto a tre dimensioni tra loro correlate: (i) gli elementi fisici del sistema energetico, ovvero tecnologia, infrastrutture, mercato, impianti di produzione, modelli di consumo e catene di distribuzione; (ii) gli attori e il loro comportamento, ovvero nuove strategie e modelli di investimento, cambiamenti di coalizioni e capacità; (iii) le regolamentazioni socio-tecnologiche, ovvero norme e politiche formali, istituzioni, mentalità e sistemi di credenze, discorsi e visioni relative alla normalità e alle pratiche sociali. La transizione è dunque multidimensionale, complessa, non lineare, non deterministica e altamente incerta e, sebbene venga spesso valutata sulla base della rapidità dei cambiamenti nella dimensione tangibile, è un processo stratificato e gremito di molteplici attori.
Poiché l’esito della transizione sarà il risultato dell’interazione tra tecnologia, istituzioni, società e protagonisti, è difficile prevederne accuratamente l’andamento e, a maggior ragione, il ritmo, parametro fondamentale con importanti implicazioni per la strategia commerciale degli attori del settore energetico. In genere, per comprendere il comportamento futuro di un fenomeno si fa affidamento ai dati storici. Tuttavia, se applicati al ritmo della transizione, tali elementi risultano incerti. La storia infatti abbonda sia di casi di transizioni lente che di transizioni avvenute rapidamente. Inoltre, il ritmo della transizione differisce a seconda dei settori e delle regioni e presenta molteplici livelli, rendendo difficile trarre conclusioni certe su scala mondiale. Volendo tentare di attingere informazioni o dati dal passato, si trascura anche un altro importante aspetto: le spinte per l’attuale processo di transizione sono profondamente diverse da quanto già accaduto. Le precedenti trasformazioni del settore energetico sono state infatti determinate dalle innovazioni, dai progressi tecnologici e/o dalle preferenze dei consumatori, mentre in quella attuale sono le politiche a svolgere un ruolo di primo piano, almeno nel breve e medio termine, finché il mercato non prenderà pienamente il sopravvento. I dati storici relativi alle precedenti transizioni offrono spunti importanti, ma non necessariamente in grado di prevedere l’andamento della transizione futura.
Quando si parla della dimensione temporale della transizione entra poi in gioco anche una componente soggettiva, in quanto i concetti di “veloce” o “lento” non sono definiti rigidamente (ad esempio, 30 anni costituiscono un ritmo lento o veloce?). Per di più, il ritmo della transizione energetica risente del costante cambiamento delle priorità dei governi, dei cicli elettorali e delle competizioni politiche.
Inoltre, da un punto di vista evolutivo, le transizioni avvenute nel corso della storia riguardavano principalmente lo sviluppo di varianti (tecnologie) in un frangente di carenza, mentre la transizione verso regimi a più basse emissioni di carbonio riguarda più che altro l’adattamento dei contesti di selezione nell’era dell’abbondanza (tramite politiche, norme e incentivi che determinano i mercati), influendo sull’equilibrio di domanda e offerta. In un contesto di carenza energetica e di aumento della domanda è possibile che si verifichi una sostituzione lenta e parziale delle fonti attualmente dominanti, le quali manterrebbero comunque un prezzo premium e potrebbero soddisfare la domanda marginale in presenza di una nuova fonte di energia più economica e dal maggiore contenuto calorifico (ad esempio il caso del legno rispetto al carbone). Tuttavia, lo scenario potrebbe assumere contorni molto diversi in un contesto di offerta abbondante e stagnazione della domanda. In questo caso è possibile che una nuova fonte di energia sostituisca completamente quella attuale. In un tale scenario, le fonti oggi dominanti non possono mantenere un prezzo premium se desiderano detenere una quota di mercato significativa.
Integrare le rinnovabili nei progetti basati sugli idrocarburi
I paesi le cui entrate statali dipendono dalla produzione di petrolio e gas sono estremamente vulnerabili ai cambiamenti del panorama energetico. Ciò vale in certa misura anche per le compagnie petrolifere. Tuttavia, tra le grandi società petrolifere e i paesi esportatori di petrolio sussistono due differenze fondamentali in relazione alla transizione energetica. Se il problema principale delle compagnie petrolifere è infatti la disruption dei modelli di business esistenti, la principale sfida dei paesi esportatori di petrolio è, oltre alla perdita di proventi essenziali per la propria economia, la capacità di monetizzare la propria vasta base di riserve. Ciò è determinato in gran parte dal fatto che il rapporto R/P accertato delle compagnie petrolifere internazionali è normalmente di circa otto-dieci anni, mentre è dell’ordine di diversi decenni per alcuni dei paesi ricchi di risorse, dunque superiore a qualsiasi previsione del picco della domanda. Nel caso dell’Arabia Saudita, dove i proventi del petrolio rappresentano il 90 percento circa del bilancio statale, è ad esempio di oltre 63 anni. L’incapacità di monetizzare la propria base di riserve costituisce dunque un rischio per questi paesi.
L’altra importante differenza è che, diversamente dalle compagnie petrolifere che potrebbero incorrere in rischi spostando il proprio core business sulle rinnovabili, per i paesi esportatori di petrolio efficienza statica e dinamica non sono in contrasto quando si tratta di ricollocarsi verso la transizione energetica. In effetti, investire nelle rinnovabili potrebbe contribuire ad aumentare ulteriormente le entrate a breve termine dei paesi esportatori di petrolio, in quanto le risorse di idrocarburi verrebbero destinate all’esportazione (purché i prezzi internazionali siano superiori al prezzo di pareggio). Grazie alle loro peculiari caratteristiche, per i paesi esportatori di petrolio la logica alla base degli investimenti nelle rinnovabili risulta assolutamente stringente. Questi paesi sono infatti caratterizzati da un aumento della domanda energetica e stanno attraversando una fase di sviluppo nella quale la crescita economica è legata al consumo di energia. Inoltre, stando alle previsioni, l’aumento della domanda energetica dovrebbe mettere a dura prova la loro capacità di esportazione. In effetti, alcuni di loro, come Kuwait e EAU, sono già importatori netti di gas naturale.
L’economia delle rinnovabili, nei paesi esportatori, dipende dal “costo opportunità” del consumo nazionale di petrolio e gas, che si riflette sul prezzo internazionale delle risorse fossili. Secondo un rapporto del 2016 della Energy Information Administration (EIA), generare 1 MWh di elettricità richiede 1,73 barili di petrolio o 10,11 mcf (migliaia di piedi cubi) di gas naturale. I prezzi d’asta ai minimi storici per il solare fotovoltaico (FV) di Dubai, Messico, Perù, Cile, Abu Dhabi e Arabia Saudita hanno dimostrato che, nelle giuste circostanze, è possibile raggiungere un LCOE (costo livellato dell’elettricità) di 3 centesimi di dollaro/kWh. L’IRENA prevede inoltre che il costo medio globale del solare fotovoltaico si aggirerà attorno ai 6 centesimi/kWh. Se si considera la fascia inferiore (più vicina ai costi del solare nella regione), i prezzi di pareggio di petrolio e gas sarebbero rispettivamente di 17,34 dollari/b e 2,96 dollari/mcf, ben al di sotto dei livelli internazionali. Se invece prendiamo in considerazione i costi medi globali del solare (piuttosto costante nella regione), i prezzi di pareggio aumenteranno raggiungendo 34,68 dollari/b e 5,93 dollari/mcf, il che significa che saranno comunque inferiori al prezzo internazionale del petrolio, ma leggermente superiori al prezzo medio del gas naturale. Anche aggiungendo i costi legati all’intermittenza dell’energia solare (circa 5 dollari/MWh), l’economia delle rinnovabili trionfa comunque sulle risorse tradizionali in questi paesi e verrà potenziata tenendo conto degli introiti derivanti dalle esportazioni di petrolio e gas non più destinati al consumo nazionale. Ciò evidenzia l’importanza per i paesi esportatori di petrolio di integrare le rinnovabili nell’attuale mix di produzione basato sui combustibili fossili.
La diversificazione rimane fondamentale
Nei paesi esportatori di petrolio del Medio Oriente, che dipendono fortemente dai proventi del petrolio, gli investimenti nelle rinnovabili sono finalizzati alla massimizzazione delle entrate statali nel breve termine destinando gli idrocarburi all’esportazione, ma non garantiscono la sostenibilità a lungo termine. Nel lungo periodo la diversificazione delle economie rimane la principale strategia di adattamento che questi paesi devono perseguire. Le rinnovabili potrebbero sostituire le risorse fossili nel mix energetico nazionale, ma non nel bilancio statale, in quanto investire nelle rinnovabili non garantisce gli elevati introiti derivanti dal settore oil & gas.
Inoltre, pur essendo parte della strategia di diversificazione, il settore delle energie rinnovabili da solo non è in grado di soddisfare i bisogni reali di queste economie, come la creazione di nuova occupazione e il maggiore benessere dei cittadini. Durante la transizione l’industria del petrolio e del gas continuerà dunque a svolgere un ruolo chiave in queste economie, generando gli introiti necessari per espandere alcuni comparti dell’economia produttiva, quali industrie manifatturiere, agricoltura e servizi (con particolare riguardo a quei settori in cui godono di un vantaggio comparato), per aumentare la quota di prodotto interno lordo non derivante dal petrolio e, di conseguenza, diversificare le fonti di introito statale. In effetti, il settore Oil&gas potrebbe partecipare al processo di diversificazione attraverso la creazione di nuove industrie e al rafforzamento dei rapporti a monte e a valle della filiera. In un contesto in cui il ritmo della transizione rimane altamente incerto, ciò rappresenta una strategia di flessibilità per massimizzare i benefici derivanti dal capitale che genera rendite (ovvero riserve di petrolio e gas) e prepara al contempo il paese per un’era che potrebbe essere contraddistinta da stagnazione o diminuzione della domanda di petrolio. Durante il periodo di transizione, gli introiti delle esportazioni costituiranno inizialmente la maggior parte delle entrate statali, ma diminuiranno se la diversificazione procederà come previsto.
Tuttavia, raggiungere una diversificazione economica non è affatto semplice, in quanto comporta ampi cambiamenti all’interno del sistema economico, con implicazioni per il benessere dei cittadini e per la distribuzione del reddito nazionale. I paesi esportatori di petrolio devono, ad esempio, attuare dolorose riforme fiscali che porteranno alla riduzione o eliminazione dei sussidi (ad esempio carriere sottopagate nel settore energetico) e all’introduzione di tasse, come l’imposta sul reddito e quella sul valore aggiunto. Tali questioni sono, per loro natura, complesse, data la rigidità di strutture politiche e istituzioni esistenti e l’implicito contratto sociale per via del quale la mancanza di partecipazione politica viene compensata con la distribuzione dei proventi degli idrocarburi. Per questo, nonostante la possibilità di attuare riforme graduali e su piccola scala e di introdurre misure di mitigazione, non bisogna attendersi rapide trasformazioni delle economie dei paesi esportatori di petrolio.
Inoltre, resta la possibilità (non irrilevante) che questi paesi non riescano a diversificare la propria economia, con ripercussioni sul ritmo della transizione energetica globale. In altre parole, non solo la transizione energetica globale determinerà il panorama politico ed economico dei paesi esportatori di petrolio, ma l’andamento della transizione dei principali paesi esportatori determinerà a sua volta la transizione energetica globale. È una strada a doppio senso.
La dinamica di conseguenze innescata dai paesi esportatori si farà sentire anche se essi riusciranno a espandere la propria economia produttiva o se il mercato mondiale del petrolio passerà dall’attuale modello orientato alla scarsità a un mercato basato sul costo marginale nel quale gli idrocarburi non possono mantenere un prezzo premium. Ad esempio, se questi paesi riuscissero a realizzare i propri obiettivi di diversificazione, potrebbero attuare una strategia più aggressiva di monetizzazione delle proprie riserve, che determinerebbe un calo dei prezzi del petrolio e forti variazioni dei prezzi relativi dei combustibili. Ciò si ripercuoterebbe sul ritmo della transizione, a meno che tali variazioni dei prezzi relativi non venissero regolate da tasse sul carbonio, aprendo nuove questioni legate al coordinamento e alla distribuzione internazionali. D’altro canto, se la transizione non dovesse avvenire agevolmente e si traducesse in possibili interruzioni della produzione e in una volatilità eccessiva dei prezzi del petrolio, l’intero processo di transizione energetica ne risentirebbe. Tali ripercussioni contribuiscono ad aumentare l’incertezza della già complessa questione della transizione energetica attuale.